Torre dei Conti: quando la città cade e si rialza
Un rumore secco, un tonfo, un brivido che attraversa i Fori. Ieri un frammento della Torre dei Conti è crollato durante i lavori di restauro. Le immagini, diffuse in poche ore, mostrano la polvere sollevarsi accanto al Colosseo, come se Roma — ancora una volta — respirasse la propria fragilità.
Ma non è la prima volta che accade. E forse, in questa città, non sarà mai l’ultima.
La Torre dei Conti è lì da più di ottocento anni, in bilico tra passato e presente, pietra e memoria. Quando fu costruita, nel 1203, Roma era una città inquieta, attraversata da lotte tra famiglie nobili e sogni di potere. Papa Innocenzo III volle erigerla per suo fratello Riccardo Conti, a guardia del rione Monti, su un terreno che poggiava — come spesso accade qui — sulle rovine di un mondo più antico: l’esedra del Foro della Pace, il tempio fatto costruire da Vespasiano.
Fin dall’origine, dunque, la torre era una sfida al tempo: una fortezza medievale che cresceva sopra un monumento romano, segno di continuità e di orgoglio.
Si dice che all’inizio fosse alta più di cinquanta metri, rivestita di travertino lucente, così imponente da essere chiamata “Torre Secura” o “Torre Maggiore”. I Conti, che con Innocenzo III toccavano l’apice del loro potere, volevano che fosse visibile da ogni parte della città: un marchio di pietra nel paesaggio di cupole e campanili.
Poi venne il terremoto del 1348 — lo stesso che rovinò tante chiese e abbatté torri — e la Torre dei Conti si piegò, perdendo i piani superiori. Da allora non tornò mai più com’era. Rimase tronca, ferita, ma non cadde. Nel Seicento nuovi sismi la scossero ancora, e i papi fecero aggiungere enormi contrafforti per tenerla in piedi: le sue cicatrici di mattoni sono ancora visibili, segni concreti della paura e dell’ingegno di chi non voleva vederla crollare.
Camminando oggi accanto a via Cavour, tra auto e turisti distratti, la torre sembra quasi fuori posto: un residuo d’altro tempo, separata dai Fori dalla lama di via dei Fori Imperiali, sopravvissuta al riassetto urbanistico del Novecento.
Eppure proprio questo suo isolamento la rende simbolo perfetto di Roma: una città che stratifica, che conserva e distrugge nello stesso gesto.
Ogni generazione, qui, aggiunge e sottrae qualcosa. I marmi della torre, per esempio, furono smontati nel Cinquecento e riutilizzati per costruire altre opere, tra cui Porta Pia. Così, pezzi della Torre dei Conti sono sparsi nella città, come una memoria disseminata.
Roma, del resto, non muore: si scompone.
Ogni pietra diventa fondamento per qualcos’altro.
E la Torre dei Conti — ridotta, amputata, ferita — è ancora qui a ricordarcelo.
Il crollo di questi giorni, pur drammatico, non è che un nuovo capitolo di una lunga conversazione tra la città e il tempo. Ogni crepa riapre la domanda su cosa significhi “custodire” un patrimonio. Restaurare è sempre un gesto d’amore, ma anche di potere: decidere cosa salvare, e cosa lasciare andare.
Forse il vero senso della Torre sta proprio in questo equilibrio fragile tra rovina e rinascita. Non è più una fortezza, né una casa nobiliare, né un punto strategico: è un testimone.
Un frammento che ci parla della durata, ma anche della caducità di ogni costruzione umana.
Guardandola oggi, chiusa, circondata da transenne e impalcature, si potrebbe pensare a un corpo stanco, che chiede tregua. Ma a Roma le pietre non muoiono: cambiano forma, diventano parte di un racconto più grande.
La Torre dei Conti ha attraversato secoli di terremoti, demolizioni, guerre, restauri e adesso un nuovo crollo. Eppure resiste, come la città che la circonda.
Perché Roma, da sempre, cade e si rialza. Non per eroismo, ma per consuetudine: come se nel suo respiro millenario fosse scritto che ogni rovina è solo l’inizio di un’altra storia.
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)


.png)
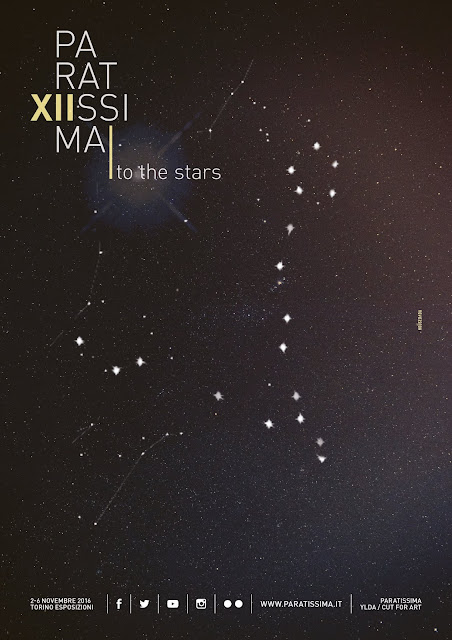
Commenti
Posta un commento